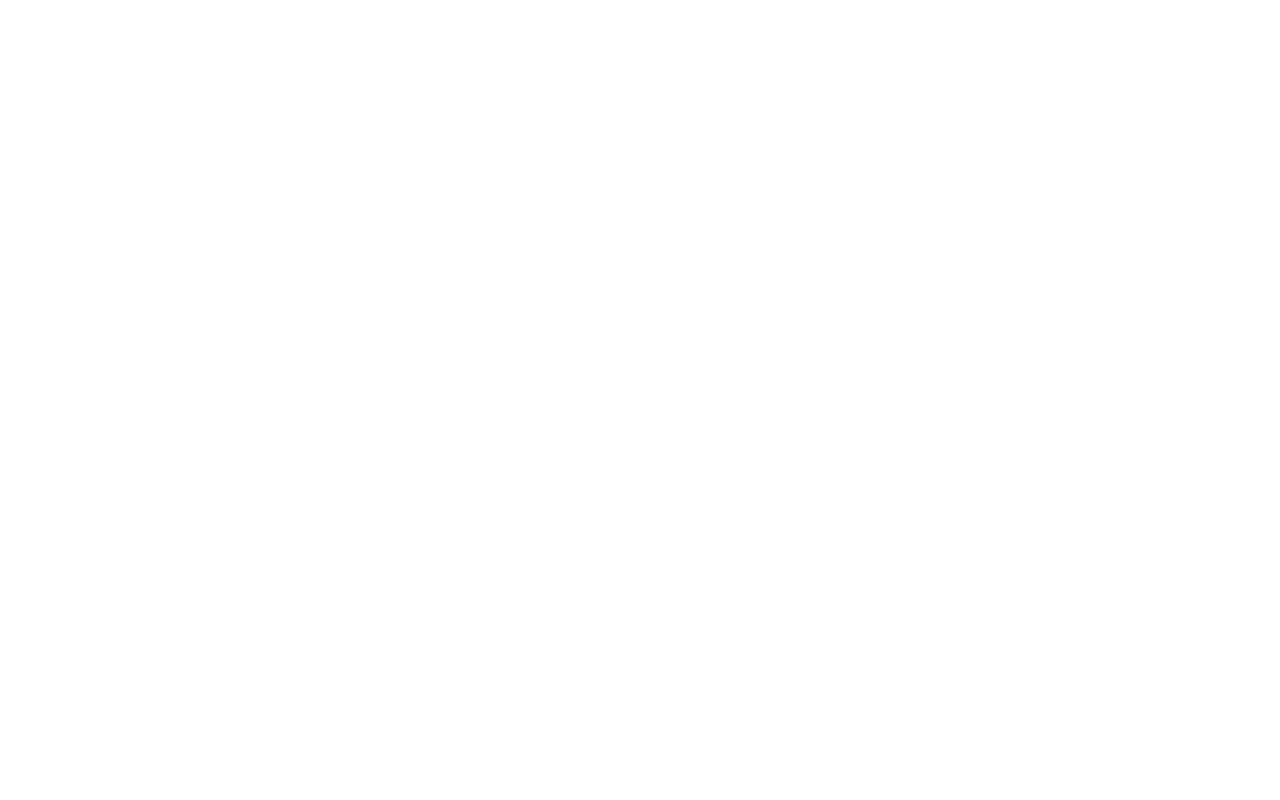STORIA MODERNA
MODERN HISTORY
Tradizione, rivoluzione e décadence nel laboratorio politico della Francia dell'Ottocento
Tradition, revolution and décadence in the political laboratory of nineteenth-century France
| A.A. | CFU |
|---|---|
| 2016/2017 | 8 |
| Docente | Ricevimento studentesse e studenti | |
|---|---|---|
| Riccardo Roni | Dopo le lezioni |
Assegnato al Corso di Studio
| Giorno | Orario | Aula |
|---|
Obiettivi Formativi
- Fornire gli strumenti concettuali e le metodologie per una riflessione approfondita sul significato del lavoro storico, focalizzando i tratti essenziali che definiscono l'età moderna e tardomoderna con particolare riguardo alla Francia nel periodo che va dal 1789 al 1914, mettendo in evidenza il ruolo che lo studio della storia ha rivestito nella cultura, nella società e nel sistema educativo.
- Acquisire e padroneggiare la semantica dei moderni concetti di potere, Stato, rappresentanza, suffragio, cesarismo, liberalismo, democrazia, comunismo, socialismo, movimento operaio, corporativismo, nazionalismo, revisionismo, reazione, rivoluzione.
- Imparare ad interrogarsi sul significato della storia come disciplina e sul mestiere di storico, estraendo dai manuali problemi e nozioni, questioni e dati per costruire in modo personale il reticolo di coordinate spazio-temporali necessarie e preliminari a ogni discorso storico.
- Sviluppare la capacità di riconoscere nella realtà che ci circonda la dimensione del tempo (dialettica della durata e pluralità dei tempi sociali).
- Riconoscere le "strutture" storiche come elementi di lunga durata.
- Imparare ad apprendere il passato per comprendere le società e le civiltà del presente, recuperando l'elemento dinamico, il divenire storico, e per costruire identità collettive in cui riconoscersi.
- Apprendere la storia come strumento per un'educazione civica e per la sopravvivenza delle civiltà.
Programma
Lo storico francese Marc Bloch (1886-1944), fondatore assieme a Lucien Febvre della rivista delle "Annales", spiegava che il compito dello storico consiste nel cogliere il cambiamento, ossia "comprendere il presente mediante il passato e il passato mediante il presente". Da questo dibattito sul tempo - lo storico dovrebbe vedere le cose in questa specie di quarta dimensione - è emersa un'importante riflessione sul metodo storico, esposta in un celebre articolo di Fernand Braudel (1902-1985) pubblicato sulla rivista "Annales" nel 1958, nel quale egli riprende il concetto di durata - originariamente impiegato dallo psicologo Victor Egger in relazione agli stati di coscienza individuali e poi ripreso dal celebre filosofo Henri Bergson - applicandolo alla storia, per poter cogliere la pluralità del tempo sociale, appunto una "lunga durata" i cui ritmi sono molteplici a seconda dei fenomeni studiati. Sulla base di questo assunto metodologico, il corso si propone di ricostruire il quadro storico e politico della Francia dell'Ottocento sino alla Grande Guerra, focalizzando, da un lato, sull'affermazione dei diritti umani e di cittadinanza e sull'esperienza di repubblica democratica, ma mettendo in evidenza, nel contempo, la reazione di una larga parte della cultura francese alla trasformazione in atto dei rapporti sociali e delle regole gerarchiche consolidate da secoli. Una reazione scattata contro i "diritti civili" agli inizi del secolo, i diritti politici nel 1848-49, la Repubblica parlamentare nel 1898-99, e più in generale contro i progressi della democrazia, del socialismo, del movimento operaio e dell'individualismo liberale, che portò molti intellettuali francesi (come de Bonald, de Maistre, Renan, Taine o Le Bon), ma anche tedeschi (come nel caso di Nietzsche), ad elaborare nuovi modelli organici di ordine gerarchico che molto contribuiranno a mettere in crisi l'idea di democrazia negli anni trenta del Novecento.
Risultati di Apprendimento (Descrittori di Dublino)
- Lo studente dovrà mostrare il possesso delle conoscenze di base relative alla Storia moderna (nozioni, periodizzazioni, concetti e teorie), con particolare riferimento ai suoi elementi costitutivi (problemi e metodi) e soprattutto ai rapporti con le altre scienze sociali e alle scienze dell'educazione.
- Lo studente dovrà mostrare la comprensione dei concetti e delle teorie previsti dal corso, adottando lo sguardo dello storico e fornendo esempi di periodizzazione e di ricostruzione delle teorie politiche che caratterizzano l'età moderna e tardomoderna.
- Lo studente dovrà mostrare il possesso della capacità di distinguere la storia generale e le storie speciali, impostando con adeguati metodi le fasi della ricerca storica e della didattica.
Materiale Didattico
Il materiale didattico predisposto dalla/dal docente in aggiunta ai testi consigliati (come ad esempio diapositive, dispense, esercizi, bibliografia) e le comunicazioni della/del docente specifiche per l'insegnamento sono reperibili all'interno della piattaforma Moodle › blended.uniurb.it
Modalità Didattiche, Obblighi, Testi di Studio e Modalità di Accertamento
- Modalità didattiche
Lezioni frontali
- Obblighi
Si consiglia la frequenza del corso
- Testi di studio
- P. VIOLA, L'Ottocento, Einaudi, Torino 2000.
- P. PRODI, Introduzione allo studio della storia moderna, Il Mulino, Bologna 2016, pp. 13-165.
- M. BATTINI, L'ordine della gerarchia. I contributi reazionari e progressisti alle crisi della democrazia in Francia 1789-1914, Bollati Boringhieri, Torino 1995: LE SEGUENTI PARTI: CAP. 1 (paragrafi 1,2,3,6,7); CAP. 2 (paragrafi 1,2,6); CAP. 3 (paragrafi 1,5); CAP. 4 (paragrafi 1,3); EPILOGO (paragrafo 2).
- K. MARX-F. ENGELS, Manifesto del partito comunista (1848), a cura di D. Losurdo, Laterza, Roma-Bari 1999, solo parte terza, pp. 39-53.
- F. NIETZSCHE, Sull'utilità e il danno della storia per la vita (1874), Adelphi, Milano 1974 (o successive edizioni).
- F. BRAUDEL, Storia e scienze sociali. La "lunga durata" (1958), in ID., Scritti sulla storia, Bompiani, Milano 2001, pp. 37-72.
- R. RONI (a cura di), Victor Egger e Henri Bergson. Alle origini del flusso di coscienza, Edizioni ETS, Pisa 2016.
- Modalità di
accertamento Esame orale
- Disabilità e DSA
Le studentesse e gli studenti che hanno registrato la certificazione di disabilità o la certificazione di DSA presso l'Ufficio Inclusione e diritto allo studio, possono chiedere di utilizzare le mappe concettuali (per parole chiave) durante la prova di esame.
A tal fine, è necessario inviare le mappe, due settimane prima dell’appello di esame, alla o al docente del corso, che ne verificherà la coerenza con le indicazioni delle linee guida di ateneo e potrà chiederne la modifica.
Informazioni aggiuntive per studentesse e studenti non Frequentanti
- Modalità didattiche
Lezioni frontali
- Testi di studio
- P. VIOLA, L'Ottocento, Einaudi, Torino 2000.
- P. PRODI, Introduzione allo studio della storia moderna, Il Mulino, Bologna 2016, pp. 13-165.
- M. BATTINI, L'ordine della gerarchia. I contributi reazionari e progressisti alle crisi della democrazia in Francia 1789-1914, Bollati Boringhieri, Torino 1995. LE SEGUENTI PARTI: CAP. 1 (paragrafi 1,2,3,6,7); CAP. 2 (paragrafi 1,2,6); CAP. 3 (paragrafi 1,5); CAP. 4 (paragrafi 1,3); EPILOGO (paragrafo 2).
- K. MARX-F. ENGELS, Manifesto del partito comunista (1848), a cura di D. Losurdo, Laterza, Roma-Bari 1999, solo parte terza, pp. 39-53.
- F. NIETZSCHE, Sull'utilità e il danno della storia per la vita (1874), Adelphi, Milano 1974 (o successive edizioni).
- F. BRAUDEL, Storia e scienze sociali. La "lunga durata" (1958), in ID., Scritti sulla storia, Bompiani, Milano 2001, pp. 37-72.
- R. RONI (a cura di), Victor Egger e Henri Bergson. Alle origini del flusso di coscienza, Edizioni ETS, Pisa 2016.
- Modalità di
accertamento Orale
- Disabilità e DSA
Le studentesse e gli studenti che hanno registrato la certificazione di disabilità o la certificazione di DSA presso l'Ufficio Inclusione e diritto allo studio, possono chiedere di utilizzare le mappe concettuali (per parole chiave) durante la prova di esame.
A tal fine, è necessario inviare le mappe, due settimane prima dell’appello di esame, alla o al docente del corso, che ne verificherà la coerenza con le indicazioni delle linee guida di ateneo e potrà chiederne la modifica.
| « torna indietro | Ultimo aggiornamento: 22/02/2017 |