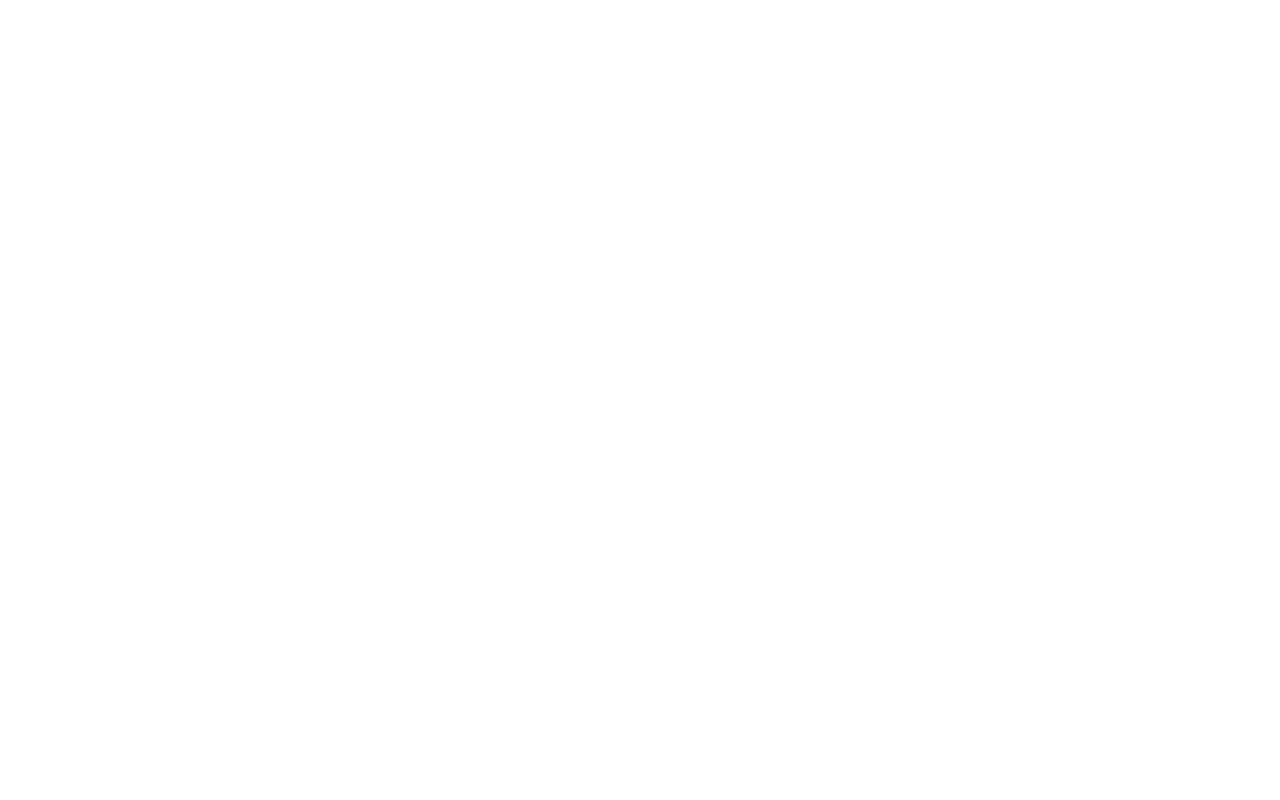CHIMICA PER IL RESTAURO
CHEMISTRY FOR THE RESTORATION
| A.A. | CFU |
|---|---|
| 2025/2026 | 4 |
| Docente | Ricevimento studentesse e studenti | |
|---|---|---|
| Maria Letizia Amadori | Lunedì ore 13-15 |
| Didattica in lingue straniere |
|---|
|
Insegnamento con materiali opzionali in lingua straniera
Inglese
La didattica è svolta interamente in lingua italiana. I materiali di studio e l'esame possono essere in lingua straniera. |
Assegnato al Corso di Studio
| Giorno | Orario | Aula |
|---|
| Giorno | Orario | Aula |
|---|
Obiettivi Formativi
Il corso si pone come obiettivo quello di fornire agli studenti approfondimenti sulla chimica dei materiali costitutivi dei beni culturali e le loro interazioni con i fattori ambientali e antropici. Saranno approfondite le tecniche diagnostiche utilizzate per identificare i processi di degrado in atto sui materiali costitutivi i beni culturali. Infine verranno affrontate le caratteristiche chimiche di alcuni materiali utilizzati nel restauro.
Programma
Introduzione alla chimica dei materiali costitutivi dei beni culturali e disanima sul ruolo dello sviluppo delle conoscenze chimiche in funzione del restauro dei materiali;; cenni sui processi di inquinamento responsabili di processi di degrado dei beni culturali; interazioni tra materiale e ambiente con un focus sui processi chimici alla base del degrado; tecniche diagnostiche per identificare i processi di degrado dei manufatti artistici; principali prodotti utilizzati nel restauro, con cenni sulla tossicità; nuovi prodotti sostenibili per il restauro.
Nel dattaglio, il programma si sviluppa come segue:
- Materiali pittorici (tele, tavole e dipinti murali) e interazioni con l'ambiente. Tipologie di degrado. Diagnostica. Prodotti impiegati nel restauro. Casi studio
- Materiali lapidei (naturali e artificiali) e interazioni con l'ambiente. Tipologie di degrado. Diagnostica. Prodotti impiegati nel restauro. Casi studio
- Materiali pittorici (tele, tavole e dipinti murali) e interazioni con l'ambiente. Tipologie di degrado. Diagnostica. Prodotti impiegati nel restauro. Casi studio
- Materiali metallici e interazione con l'ambiente. Tipologie di degrado. Diagnostica. Prodotti impiegati nel restauro. Casi studio
- Materiali cellulosici (carta e legno): e interazione con l'ambiente. Tipologie di degrado. Diagnostica. Prodotti impiegati nel restauro. Casi studio
- Materiali cellulosici (carta e legno): e interazione con l'ambiente. Tipologie di degrado. Diagnostica. Prodotti impiegati nel restauro. Casi studio
Eventuali Propedeuticità
Chimica Generale e Inorganica; Chimica Organica; Chimica per i Beni Culturali; Chimica Analitica per i Beni Culturali
Risultati di Apprendimento (Descrittori di Dublino)
Studenti e studentesse acquisiranno le competenze base necessarie alla comprensione delle diverse caratteristiche dei materiali di interesse per i beni culturali e matureranno una conoscenza critica dei fattori ambientali che portano al degrado degli stessi, delle tecniche e modalità di conservazione e restauro.
D1 - Conoscenza e capacità di comprensione. Lo studente dovrà conoscere composizione dei materiali costitutivi i Beni Culturali e la loro interazione con l'ambiente. Dovrà conoscere l’importanza delle loro caratteristiche originarie e il degrado che possono subire nel tempo. Dovrà inoltre conoscere quali sono le metodologie diagnostiche utili ai fine della conoscenza e del restauro dei beni culturali. Il livello di queste conoscenze viene valutato con domande orali e con verifica al microscopio.
D2 - Capacità di applicare conoscenza e comprensione. Lo studente dovrà essere in grado di capire in che modo le caratteristiche marco e microscopiche di un materiale sono correlate alle diverse tipologie di degrado. Questo gli permetterà di capire quale approccio dovrà essere impiegato per progettare un eventuale progetto di diagnostica e di restauro. Queste competenze verranno valutate durante il colloquio orale chiedendo di mostrare degli esempi anche relativi a manufatti studiati nei corsi di laboratorio di restauro o nell’ambito di tesi di laurea o tesine di abilitazione.
D3 - Autonomia di giudizio. Lo studente dovrà essere in grado di scegliere la tipologia di indagine più adatta per identificare un materiale e il rispettivo stato di conservazione in virtù di un eventuale restauro.. Queste competenze derivano direttamente dalle due precedentemente descritte e dalla capacità di progettare un progetto di diagnostica volto anche all’intervento di restauro che viene affrontato nei corsi di laboratorio. Questa competenza verrà valutata durante il colloquio orale.
D4 - Abilità comunicative. Lo studente dovrà essere in grado di esprimere i concetti e le informazioni appresi durante il corso esprimendosi in modo adeguato, con termini idonei, portando opportuni esempi e dimostrando di avere assimilato le nozioni apprese durante il corso stesso. Durante il colloquio orale lo studente dovrà illustrare alcuni concetti e nozioni attraverso i quali il docente valuterà la sua competenza e proprietà di sintesi.
D5 - Capacità di apprendimento. Lo studente dovrà essere capace di realizzare un uno sviluppo critico nel proprio percorso scientifico in piena autonomia, utilizzando adeguatamente i materiale di studio fornito dal docente, le esercitazioni effettuate in laboratorio e il materiale di approfondimento che potrà procurarsi. Il docente cercherà di stimolare tali azioni e proporrà approfondimenti su varie tematiche e casi studio e articoli scientifici su materiali costitutivi e diagnostica che potranno essere discussi in modo critico durante le varie lezioni. Tale abilità verrà valutata attraverso il colloquio orale.
Materiale Didattico
Il materiale didattico predisposto dalla/dal docente in aggiunta ai testi consigliati (come ad esempio diapositive, dispense, esercizi, bibliografia) e le comunicazioni della/del docente specifiche per l'insegnamento sono reperibili all'interno della piattaforma Moodle › blended.uniurb.it
Attività di Supporto
Sono previste esercitazioni di laboratorio (ore 4) condotte dalla dott.ssa Valeria Mengacci o dal dottor Jgor Arduini
Modalità Didattiche, Obblighi, Testi di Studio e Modalità di Accertamento
- Modalità didattiche
Il corso prevede lezioni frontali in cui il docente espone nozioni e concetti e laboratori al microscopio ottico offrendo casi studio per favorirne la comprensione.
Gli studenti possono intervenire alle lezioni per richiedere chiarimenti al docente o comunicare attraverso la piattaforma o via email.
- Obblighi
no
- Testi di studio
M. Matteini, A. Moles, La chimica nel restauro, Ed. Nardini, Firenze, 1989.
- L. Campanella, A. Casoli, M.P. Colombini, R. Marini Bettolo, M. Matteini, L.M. Migneco, A. Montenero, L. Nodari, C. Piccioli, M. Plossi Zappala', G. Portalone, U. Russo, M.P. Sammartino, Chimica per l'arte, Zanichelli editore , 2007.
- M.Matteini e a. Moles, Scienza e restauro. Metodi di indagine. Nardini Editore, Firenze 1984.
- Appunti e dispense delle lezioni.I testi devono essere studiati per intero.
- Modalità di
accertamento L'accertamento dell'apprendimento prevede un colloquio orale sul programma di insegnamento, una prova in laboratorio al microscopio ottico e la discussione di un articolo scientifico fornito dal Docente prima dell’esame.
Colloquio orale: Il colloquio orale verterà sugli aspetti generali del programma la cui conoscenza è richiesta. La/o studentessa/e sceglierà uno dei materiali indicati nel programma su cui sarà verificata l’abilità a studiare al microscopio ottico uno degli argomenti affrontati in laboratorio e sul quale verrà interrogata/o.
Discussione dell’articolo scientifico: alla fine del corso il Docente fornirà a ciascuno studente un articolo scientifico pertinente al corso, che può essere anche in lingua inglese, da leggere, comprendere e sapere riassumere in sede di esame.
Criteri e parametri di valutazione:
- Conoscenza dei concetti. a) Insufficiente. Descrive in modo approssimativo i costrutti concettuali; scarsa comprensione b) Sufficiente. Descrive con qualche imprecisione i costrutti. Assenza di riferimenti agli autori; buona comprensione. c) Buono. Descrive in maniera precisa i costrutti concettuali; buona comprensione. d) ottimo. Descrive in modo sistematico i costrutti; piena comprensione.
- Conoscenza di tecniche e procedure. a) Insufficiente. Non è in grado di utilizzare strumenti matematici di base per la comprensione di leggi o formule. b) Sufficiente. E' in grado di discutere leggi o formule. c) Buono. E' in grado di utilizzare strumenti matematici di base per la comprensione di leggi o formule. d) Ottimo. Discute leggi o formule utilizzando basi fisico-matematiche adeguate.
- Padronanza del linguaggio. a) Insufficiente. Si esprime con un linguaggio comune non specifico. b) sufficiente. Dimostra capacità di espressione limitata; usa alcuni termini specifici . c) Dimostra buona capacità di espressione e uso di alcuni termini specifici. d) ottimo. Dimostra piena padronanza del linguaggio specifico
- Esercizio critico. a) insufficiente. Non sa individuare le ragioni di quanto sostiene; Non sa individuare aspetti positivi/negativi; Non sa individuare esempi. b) sufficiente. Non individua aspetti diversi delle problematiche se non in maniera generale; Fornisce gli esempi del libro/della lezione. c) Buono. Fornisce esempi pertinenti; Differenzia aspetti diversi. d) Argomenta in maniera coerente; Formula esempi pertinenti; Individua aspetti negativi/positivi
Le studentesse e gli studenti che hanno registrato la certificazione di disabilità o la certificazione di DSA presso l'Ufficio Inclusione e diritto allo studio, possono chiedere di utilizzare le mappe concettuali (per parole chiave) durante la prova di esame. A tal fine, è necessario inviare le mappe due settimane prima dell’appello di esame, alla docente del corso, che ne verificherà la coerenza con le indicazioni delle linee guida di Ateneo e potrà chiederne la modifica.
- Disabilità e DSA
Le studentesse e gli studenti che hanno registrato la certificazione di disabilità o la certificazione di DSA presso l'Ufficio Inclusione e diritto allo studio, possono chiedere di utilizzare le mappe concettuali (per parole chiave) durante la prova di esame.
A tal fine, è necessario inviare le mappe, due settimane prima dell’appello di esame, alla o al docente del corso, che ne verificherà la coerenza con le indicazioni delle linee guida di ateneo e potrà chiederne la modifica.
Informazioni aggiuntive per studentesse e studenti non Frequentanti
- Modalità didattiche
Le studentesse e gli studenti possono richiedere alcune ore di laboratorio al di fuori delle ore di lezione solo se lavoratori.
- Obblighi
no
- Testi di studio
M. Matteini, A. Moles, La chimica nel restauro, Ed. Nardini, Firenze, 1989.
- L. Campanella, A. Casoli, M.P. Colombini, R. Marini Bettolo, M. Matteini, L.M. Migneco, A. Montenero, L. Nodari, C. Piccioli, M. Plossi Zappala', G. Portalone, U. Russo, M.P. Sammartino, Chimica per l'arte, Zanichelli editore , 2007.
- M.Matteini e a. Moles, Scienza e restauro. Metodi di indagine. Nardini Editore, Firenze 1984.
- Appunti e dispense delle lezioni.I testi devono essere studiati per intero.
- Modalità di
accertamento L'accertamento dell'apprendimento prevede un colloquio orale sul programma di insegnamento, una prova in laboratorio al microscopio ottico e la discussione di un articolo scientifico fornito dal Docente prima dell’esame.
Colloquio orale: Il colloquio orale verterà sugli aspetti generali del programma la cui conoscenza è richiesta. La/o studentessa/e sceglierà uno dei materiali indicati nel programma su cui sarà verificata l’abilità a studiare al microscopio ottico uno degli argomenti affrontati in laboratorio e sul quale verrà interrogata/o.
Discussione dell’articolo scientifico: alla fine del corso il Docente fornirà a ciascuno studente un articolo scientifico pertinente al corso, che può essere anche in lingua inglese, da leggere, comprendere e sapere riassumere in sede di esame.
Criteri e parametri di valutazione:
- Conoscenza dei concetti. a) Insufficiente. Descrive in modo approssimativo i costrutti concettuali; scarsa comprensione b) Sufficiente. Descrive con qualche imprecisione i costrutti. Assenza di riferimenti agli autori; buona comprensione. c) Buono. Descrive in maniera precisa i costrutti concettuali; buona comprensione. d) ottimo. Descrive in modo sistematico i costrutti; piena comprensione.
- Conoscenza di tecniche e procedure. a) Insufficiente. Non è in grado di utilizzare strumenti matematici di base per la comprensione di leggi o formule. b) Sufficiente. E' in grado di discutere leggi o formule. c) Buono. E' in grado di utilizzare strumenti matematici di base per la comprensione di leggi o formule. d) Ottimo. Discute leggi o formule utilizzando basi fisico-matematiche adeguate.
- Padronanza del linguaggio. a) Insufficiente. Si esprime con un linguaggio comune non specifico. b) sufficiente. Dimostra capacità di espressione limitata; usa alcuni termini specifici . c) Dimostra buona capacità di espressione e uso di alcuni termini specifici. d) ottimo. Dimostra piena padronanza del linguaggio specifico
- Esercizio critico. a) insufficiente. Non sa individuare le ragioni di quanto sostiene; Non sa individuare aspetti positivi/negativi; Non sa individuare esempi. b) sufficiente. Non individua aspetti diversi delle problematiche se non in maniera generale; Fornisce gli esempi del libro/della lezione. c) Buono. Fornisce esempi pertinenti; Differenzia aspetti diversi. d) Argomenta in maniera coerente; Formula esempi pertinenti; Individua aspetti negativi/positivi
Le studentesse e gli studenti che hanno registrato la certificazione di disabilità o la certificazione di DSA presso l'Ufficio Inclusione e diritto allo studio, possono chiedere di utilizzare le mappe concettuali (per parole chiave) durante la prova di esame. A tal fine, è necessario inviare le mappe due settimane prima dell’appello di esame, alla docente del corso, che ne verificherà la coerenza con le indicazioni delle linee guida di Ateneo e potrà chiederne la modifica.
- Disabilità e DSA
Le studentesse e gli studenti che hanno registrato la certificazione di disabilità o la certificazione di DSA presso l'Ufficio Inclusione e diritto allo studio, possono chiedere di utilizzare le mappe concettuali (per parole chiave) durante la prova di esame.
A tal fine, è necessario inviare le mappe, due settimane prima dell’appello di esame, alla o al docente del corso, che ne verificherà la coerenza con le indicazioni delle linee guida di ateneo e potrà chiederne la modifica.
| « torna indietro | Ultimo aggiornamento: 16/06/2025 |