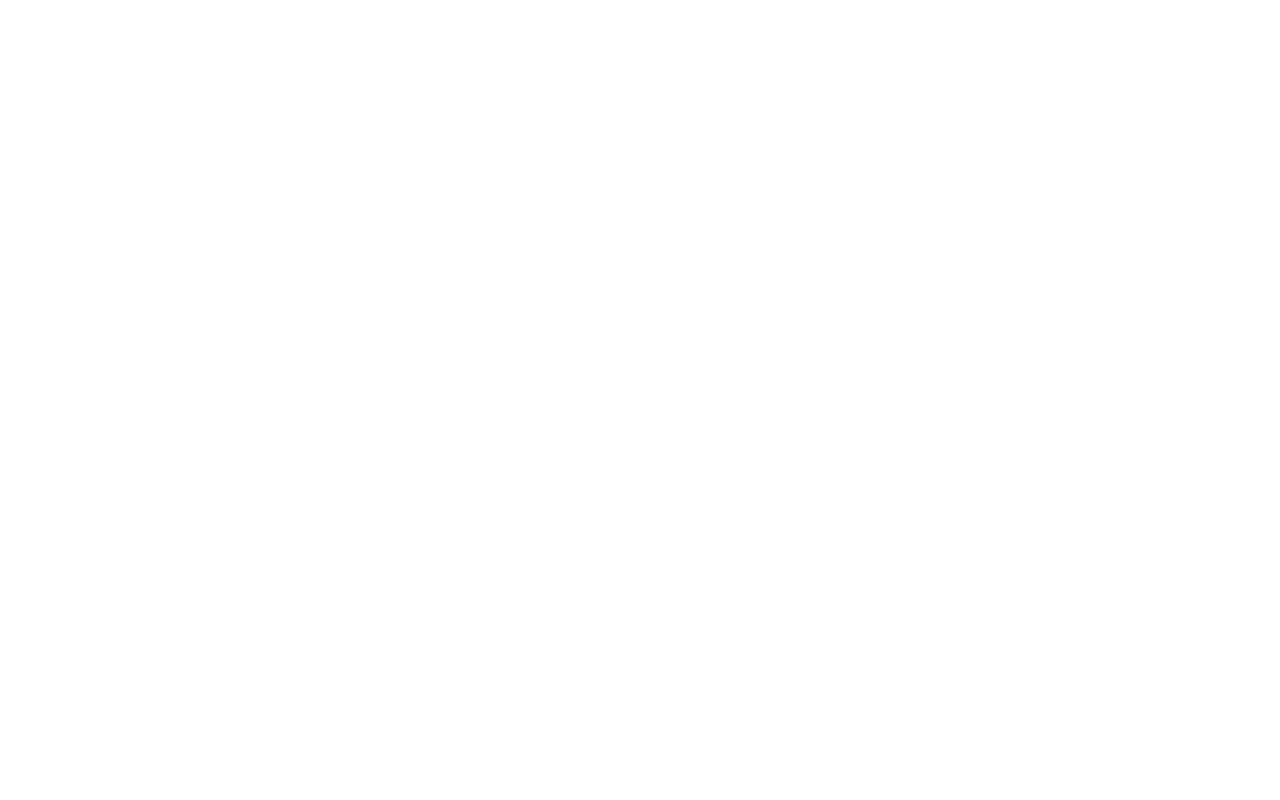CHIMICA ORGANICA I
ORGANIC CHEMISTRY I
| A.A. | CFU |
|---|---|
| 2025/2026 | 9 |
| Docente | Ricevimento studentesse e studenti | |
|---|---|---|
| Fabio Mantellini | Dal Lunedì al Venerdì previo appuntamento. |
| Didattica in lingue straniere |
|---|
|
Insegnamento con materiali opzionali in lingua straniera
Inglese
La didattica è svolta interamente in lingua italiana. I materiali di studio e l'esame possono essere in lingua straniera. |
Assegnato al Corso di Studio
| Giorno | Orario | Aula |
|---|
| Giorno | Orario | Aula |
|---|
Obiettivi Formativi
L'obiettivo formativo del corso è la comprensione da parte degli Studenti delle caratteristiche strutturali, della nomenclatura, delle proprietà chimico-fisiche e della reattività delle principali classi di composti organici attraverso lo studio dei principali meccanismi di reazione. Vengono inoltre riportate indicazioni sull’utilizzo di tali derivati organici come materie prime in processi industriali e sul loro ruolo come sostanze inquinanti.
Programma
Sostituzione nucleofila al carbonio saturo
Meccanismo della sostituzione nucleofila del primo (SN1)e del secondo ordine (SN2), contrasti tra SN1 e SN2, il gruppo uscente nelle reazioni SN1 e SN2, il nucleofilo nelle reazioni SN1, il nucleofilo nelle reazioni SN2, nucleofili e gruppi uscenti a confronto, reazioni di eliminazioni e riarrangiamento.
Reazioni di eliminazione
Sostituzione ed eliminazione, come il nucleofilo influenza l’eliminazione rispetto alla sostituzione, meccanismi E1 ed E2. La struttura del substrato può consentire la E1, regola del gruppo uscente, Stereoselettività nelle reazioni E1, stato di transizione periplanare nelle E2, regioselettività nelle E2, Anioni stabilizzati e meccanismo alternativo E1cB.
Revisione dei metodi spettroscopici
Spettroscopia e chimica del gruppo carbonilico, spettroscopia IR dei derivati degli acidi carbossilici, analisi spettroscopica di anelli ciclici tensionati ed alchini, prevedere la frequenza di stiramento del carbonile, analisi conformazionale del cicloesano tramite spettroscopia NMR, Accoppiamenti tra eteronuclei, identificazione spettroscopica dei prodotti.
Addizione elettrofila agli alcheni
Addizione del bromo, ossidazione degli alcheni ad epossidi, regioselettività ad alcheni asimmetrici, addizione elettrofila ai dieni, reazioni regioselettive di apertura degli ioni bromonio asimmetrici, addizioni elettrofile stereospecifiche, diidrossilazione, rompere completamente il doppio legame carbonio-carbonio: scissione con periodato e ozonolisi. Addizione di acqua al doppio legame.
Preparazione e reattività di enoli ed enolati.
Tautomeria: formazione degli enoli per trasferimento di un protone, equilibrio cheto-enolico per aldeidi e chetoni, evidenze sperimentali dell’equilibrio cheto-enolico, enolizzazione acido e base catalizzata, enoli stabili, conseguenze dell’enolizzazione, rreazioni che prevedono enoli ed enolati come intermedi, equivalenti stabili degli anioni enolato, reazionidi enoli ed enolati all’ossigeno: preparazione degli enol eteri e loro reazioni.
Sostituzioni elettrofile aromatiche
Enoli e fenoli, sostituzione elettofila, effetti attivanti/disattivanti dei sostituenti presenti sull’anello aromatico, effetti orientanti dei sostituenti presenti sull’anello aromatico, reazioni su composti aromatici polisostituiti, peculiarità delle reazioni di sostituzione elettrofile aromatiche: vantaggi e svantaggi. Le reazioni di Friedel Craft. Sfruttare la chimica del gruppo nitro.
Addizioni coniugate e sostituzioni nucleofile aromatiche
Alcheni coniugati con gruppi carbonilici: comportamento elettrofilo dell’alchene e del carbonile: addizioni coniugate e addizioni dirette. Fattori che guidano la regioselettività. reazioni di sostituzione coniugata, epossidazione nucleofila, sostituzione nucleofila aromatica, il meccanismo di addizione eliminazione,: Reazioni di sostituzione nucleofila via SN1: Sali di diazonio. Il meccanismo via benzino.
Chemoselettività e gruppi protettori
Cosa si intende per selettività, agenti riducenti, riduzione dei gruppi carbonilici, idrogenazione catalitica, rimozione di gruppi funzionali, riduzione per dissoluzione di metalli, selettività nelle reazioni di ossidazione, Reattività competitiva: quale gruppo reagisce? Gruppi protettori.
Regioselettività
regioselettività nelle sostituzioni elettrofile aromatiche, attacco elettrofilico su alcheni, regioselettività nelle reazioni radicaliche, attacco nucleofilico su composti allilici, attacco elettrofilico su dieni coniugati, addizioni coniugate, esempi di reazioni regioselettive.
Alchilazione di enolati
Diverse reattività dei derivati carbonilici, Alchilazione di nitrili e nitroalcani, scelta dell’eletteofilo per l’alchilazione, enolati di litio di composti carbonilici e loro alchilazione, equivalenti sintetici specifici per l’alchilazione di aldeidi e chetoni, alchilazione di composti beta dicarbonilici, regioselettività dell’alchilazione dei chetoni, accettori di Michael.
Condensazione aldolica e condensazione di Claisen
La reazione aldolica, nucleofili equivalenti degli enoli, controllo delle reazioni aldoliche di esteri, di aldeidi e dei chetoni. reazioni aldoliche intramolecolari, acilazioni al carbonio, condensazioni di esteri incrociate, sintesi di chetoesteri mediante reazione di Claisen, reazioni di Claisen incrociate intramolecolari.
Zolfo, silicio e fosforo in chimica organica.
Anioni stabilizzati dallo zolfo, i Sali di solfonio, le ilidi di solfonio, confronto tra silicio e carbonio, nucleofilia dei silani allilici, sintesi selettiva degli alcheni. Sintesi selettiva degli alcheni, relazione proprietà alcheni-geometria, equilibri degli alcheni, sintesi stereoselettiva di alcheni a partire dagli alchini, alcheni E tramite reazioni stereoselettiva agli alchini. Olefinazione di Julia, reazione di Wittig.
Analisi retrosintetica
Disconnessioni riconducibili a reazioni note, i sintoni, sintesi multistep: controllo della chemoselettività, interconversione del gruppo funzionale, disconnessioni C-C: materiali di partenza, sintoni donatori e accettori, gruppi funzionali con una relazione 1,5, reattività naturale e umpolung.
Eterocicli aromatici: reazioni
Composti aromatici eteroatomici, la piridina, eterocicli aromaticin a sei termini contenenti ossigeno, eterocicli pentatomici come substrati per sostituzioni elettrofile: furano, pirrolo e tiofene. Anelli a cinque e sei termini con due atomi di azoto. eterocicli benzo-fusi, chinolina, e isochinolina. Eterocicli azotati conteneti zolfo e ossigeno.
Eterocicli aromatici: sintesi
Sintesi di eterocicli: considerazioni termodinamiche, sintesi di pirroli, tiofeni e furani da composti 1,4-dicarbonilici. sintesi di Hantzsch. Sintesi di pirazoli e piridazine da idrazina e composti dicarbonilici. Sintesi delle pirimidine, degli isossazoli. Cicloaddizioni per la sintesi di tetrazoli e triazoli. Sintesi di Fischer degli indoli. Sintesi di chinoline isochinoline. i tre approcci principali per la sintesi di eterocicli aromatici.
Risultati di Apprendimento (Descrittori di Dublino)
• La studentessa e lo studente dovranno dimostrare le conoscenze delle reazioni organiche che contraddistinguono le sostanze organiche. Inoltre, dovranno dimostrare di essere in grado di progettare sequenze sintetiche che coinvolgono più reazioni che consentono di elaborare processi di formazione di molecole complesse.
• La studentessa e lo studente dovranno mostrare di applicare le proprie conoscenze, capacità di comprensione e abilità nel risolvere problemi a tematiche correlate al comportamento delle sostanze organiche inserite in un contesto generale.
• La studentessa e lo studente dovranno dimostrare di saper comunicare in modo chiaro con un linguaggio chimico adeguato le proprie conclusioni, nonché le conoscenze e la ratio ad esse sottese, a interlocutori specialisti e non specialisti.
• La studentessa e lo studente dovranno sviluppare la capacità di sviluppare il suo percorso di crescita scientifica in maniera critica ed autonoma, essendo in grado di utilizzare correttamente il materiale di studio fornito dal docente e il materiale di approfondimento che lui stesso potrà procurarsi. Queste abilità, per quanto possibile, verranno stimolate dal docente proponendo approfondimenti e fornendo esercizi da risolvere a casa durante il corso, che poi verranno spiegati e discussi durante le lezioni o le ore di attività di supporto.
Materiale Didattico
Il materiale didattico predisposto dalla/dal docente in aggiunta ai testi consigliati (come ad esempio diapositive, dispense, esercizi, bibliografia) e le comunicazioni della/del docente specifiche per l'insegnamento sono reperibili all'interno della piattaforma Moodle › blended.uniurb.it
Attività di Supporto
Esercitazioni Extra curriculari tenute da un diverso Docente. E' prevista una prova di valutazione formativa (di autovalutazione), svolta al termine del corso e facoltativa, consistente in un elaborato scritto composto da cinque domande a risposta aperta.
Modalità Didattiche, Obblighi, Testi di Studio e Modalità di Accertamento
- Modalità didattiche
Lezioni frontali ed esercitazioni
- Didattica innovativa
Problem-based learning. Per un apprendimento basato sulla risoluzione di problemi.
- Testi di studio
Jonathan Clayden, Nick Greeves, Stuart Warren, Chimica Organica , Edizione italiana sulla seconda inglese. Piccin Editore
- Modalità di
accertamento Gli obiettivi previsti sono verificati attraverso due tipi di prove.
1. Una prova di valutazione parziale facoltativa incentrata sulla prima parte del programma, svolta durante il periodo di sospensione delle lezioni al termine del corso che consiste in un elaborato scritto composto da cinque domande a risposta aperta. Il tempo a disposizione per la prova parziale è di 90 minuti.
La prova di valutazione parziale (a cui sia stato attribuito un punteggio di almeno 18/30) può essere considerata, a scelta della studentessa o dello studente, contribuente al superamento dell’esame.
2. Un colloquio orale.
A discrezione della studentessa o dello studente che abbiano superato con un punteggio di almeno 18/30 la prova di valutazione parziale, il colloquio orale verterà sulla seconda parte del programma non oggetto della prova parziale. Il voto finale sarà determinato dalla media aritmetica delle valutazioni delle due prove, solo qualora entrambe risultino superiori o uguali a 18/30.
Il colloquio orale invece verterà sull’intero programma nel caso in cui la studentessa o lo studente decidano di non avvalersi della prova di valutazione parziale o qualora gli stessi non abbiano superato o sostenuto la prova di valutazione parziale. La durata media della prova orale è di 40 minuti.
Per entrambe le prove, i criteri di valutazione sono i seguenti:
- pertinenza e efficacia delle risposte in rapporto ai contenuti del programma;
- il livello di articolazione della risposta;
- adeguatezza del linguaggio disciplinare utilizzato.
La valutazione finale è espressa in trentesimi.
- Disabilità e DSA
Le studentesse e gli studenti che hanno registrato la certificazione di disabilità o la certificazione di DSA presso l'Ufficio Inclusione e diritto allo studio, possono chiedere di utilizzare le mappe concettuali (per parole chiave) durante la prova di esame.
A tal fine, è necessario inviare le mappe, due settimane prima dell’appello di esame, alla o al docente del corso, che ne verificherà la coerenza con le indicazioni delle linee guida di ateneo e potrà chiederne la modifica.
Informazioni aggiuntive per studentesse e studenti non Frequentanti
- Testi di studio
Jonathan Clayden, Nick Greeves, Stuart Warren, Chimica Organica , Edizione italiana sulla seconda inglese. Piccin Editore
- Modalità di
accertamento Gli obiettivi previsti sono verificati attraverso un colloquio orale che verterà sull’intero programma. La durata media della prova orale è di 40 minuti.
I criteri di valutazione sono i seguenti:
- pertinenza e efficacia delle risposte in rapporto ai contenuti del programma;
- il livello di articolazione della risposta;
- adeguatezza del linguaggio disciplinare utilizzato.
La valutazione finale è espressa in trentesimi.
- Disabilità e DSA
Le studentesse e gli studenti che hanno registrato la certificazione di disabilità o la certificazione di DSA presso l'Ufficio Inclusione e diritto allo studio, possono chiedere di utilizzare le mappe concettuali (per parole chiave) durante la prova di esame.
A tal fine, è necessario inviare le mappe, due settimane prima dell’appello di esame, alla o al docente del corso, che ne verificherà la coerenza con le indicazioni delle linee guida di ateneo e potrà chiederne la modifica.
| « torna indietro | Ultimo aggiornamento: 20/06/2025 |