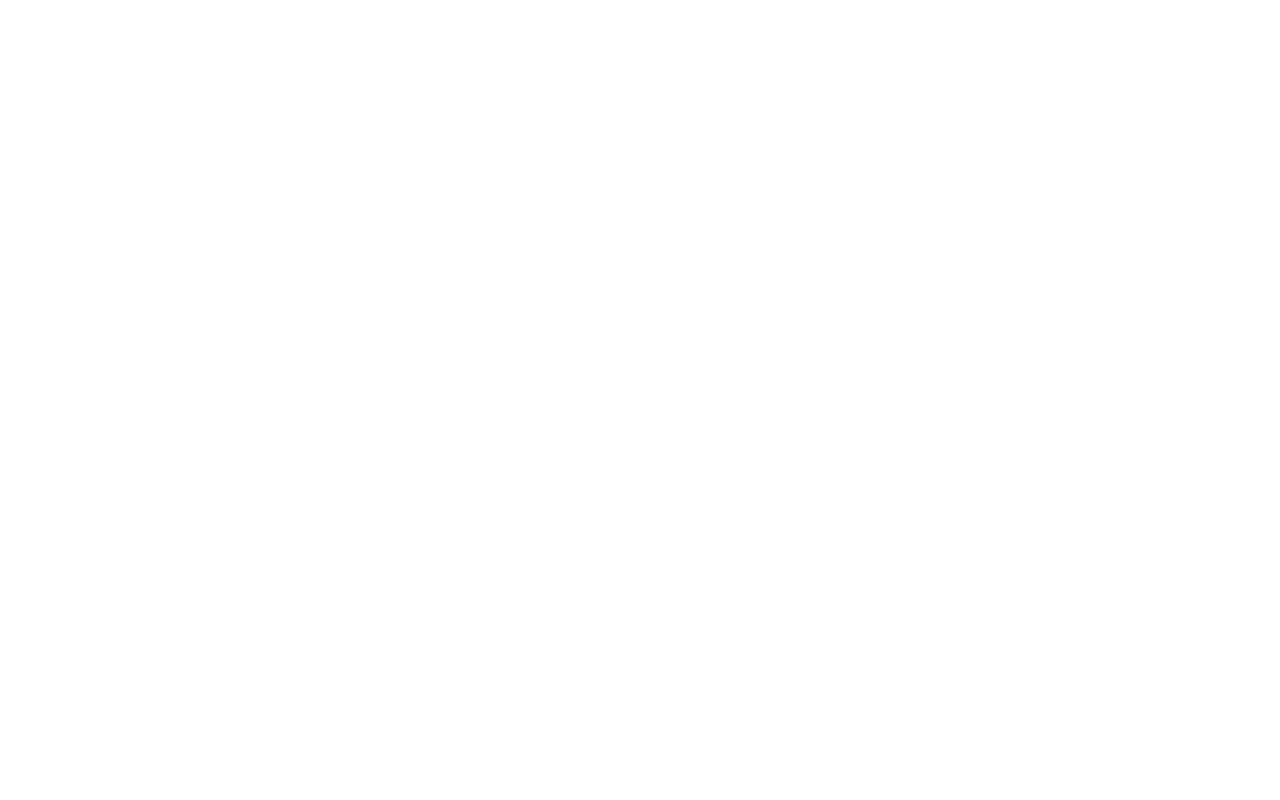SOCIOLINGUISTICA
SOCIOLINGUISTICS
| A.A. | CFU |
|---|---|
| 2025/2026 | 6 |
| Docente | Ricevimento studentesse e studenti | |
|---|---|---|
| Duccio Piccardi | Previo appuntamento per email, lunedì, 18-19 (studio del docente, Palazzo Albani) o online. |
| Didattica in lingue straniere |
|---|
|
Insegnamento con materiali opzionali in lingua straniera
Inglese
La didattica è svolta interamente in lingua italiana. I materiali di studio e l'esame possono essere in lingua straniera. |
Assegnato al Corso di Studio
| Giorno | Orario | Aula |
|---|
| Giorno | Orario | Aula |
|---|
Obiettivi Formativi
Il corso ha come finalità l’acquisizione di una serie di conoscenze teoriche di ambito sociolinguistico che lo studente potrà utilizzare per interpretare criticamente fenomeni di variazione e mutamento. Il corso mira a mettere in rilievo l'applicabilità di determinate chiavi di lettura a tutto il panorama fenomenologico riguardante l'intersezione tra lingua e società, dando ampio spazio alla scrittura. Così facendo, gli studenti saranno in grado di osservare con profondità scientifica alcuni aspetti della loro quotidianità, come la comunicazione mediata da computer. Tramite il costante confronto con le fonti, alla fine del corso lo studente potrà inoltre sapersi orientare criticamente nella letteratura scientifica del settore.
In particolare lo studente potrà:
- apprendere i fondamenti storici della sociolinguistica della variazione, le sue categorie di analisi e le sue teorie sul mutamento linguistico;
- imparare ad interpretare in chiave sociolinguistica una selezione di fenomeni riguardanti la lingua scritta;
- essere consapevole degli standard della comunicazione scientifica dello specifico settore.
Programma
Il corso si articolerà in due macrosezioni: 1) una parte introduttiva atta a presentare la sociolinguistica della variazione nei suoi fondamenti storico-disciplinari, le sue linee evolutive e le sue principali categorie d'analisi; e 2) una parte monografica sulla lingua scritta, atta a far apprezzare agli studenti la versatilità dell'analisi variazionista proponendo tentativi di interpretazione di fenomeni pertinenti.
Gli argomenti trattati nelle due sezioni del corso saranno, in particolare:
1a) La sociolinguistica della variazione: breve storia da Labov e Martha's Vineyard alla terza (quarta?) ondata.
1b) Atteggiamenti, significato sociale e indicalità. Gli studi di percezione.
1c) L'intervista laboviana e le diverse concettualizzazioni dello "stile".
1d) Le variabili sociali: la classe sociale; le comunità di pratica e le variabili centrate su forme di capitale simbolico.
1e) Le variabili sociali: sesso e genere (il "paradosso di genere"); età sociale e età anagrafica (tra tempo apparente e age-grading).
2a) Breve storia della scrittura e i tipi di sistemi di scrittura.
2b) Elementi "naturali" e elementi "culturali" nei sistemi di scrittura.
2c) Il grafosimbolismo tra significato referenziale e sociale; il suo ruolo nel fonosimbolismo.
2d) La sociolinguistica della scrittura: allografia, eterografia, digrafia; il significato sociale della mimesi e dei font.
2e) La comunicazione mediata da computer: l'indicalità nelle scelte paragrafematiche; funzioni prosodiche e paralinguistiche dell'allografia.
Eventuali Propedeuticità
Nessuna.
Risultati di Apprendimento (Descrittori di Dublino)
conoscenza e capacità di comprensione: Lo studente dovrà arrivare a conoscere una serie di nozioni volte alla comprensione delle chiavi di lettura del fenomeno linguistico fornite dalla disciplina sociolinguistica. Essendo questa di forte stampo interdisciplinare, si tratterà di apprendere nozioni di linguistica, sociologia, antropologia culturale e scienze cognitive. Lo studente dovrà inoltre essere consapevole dei processi storico-disciplinari che hanno condotto la sociolinguistica alla sua attuale fisionomia. Parallelamente sarà richiesto allo studente di imparare nozioni generali di storia della scrittura e comprendere le dinamiche di avvicinamento tra sociolinguistica e studi sulla lingua scritta.
conoscenza e capacità di comprensione applicate: Lo studente sarà invitato ad avvicinarsi alla lettura critica della letteratura del settore, in maniera tale da sviluppare la capacità di delineare percorsi individuali di ricerca bibliografica. In particolar modo lo studente dovrà iniziare a sviluppare la capacità di valutare la pertinenza delle informazioni contenute nella letteratura scientifica rispetto ai propri interessi di ricerca.
autonomia di giudizio: Lo studente dovrà arrivare a saper estrapolare autonomamente le informazioni pertinenti alle variabili sociali e all'interpretazione dei dati da un testo del settore. Dovrà altresì saper formulare un giudizio critico sul modus operandi presentato nei testi.
abilità comunicative: Lo studente dovrà essere consapevole della struttura propria di un testo scientifico del settore. Dovrà inoltre iniziare a sviluppare la capacità di relazionare in maniera sintetica sui contenuti di un testo scientifico in ambito accademico.
capacità di apprendere: Lo studente acquisirà una serie di competenze trasversali utili al proseguo della sua formazione di studioso. Sarà inoltre in grado di interpretare dinamiche identitarie della società contemporanea espresse tramite mezzi linguistici, in particolare scritti.
Materiale Didattico
Il materiale didattico predisposto dalla/dal docente in aggiunta ai testi consigliati (come ad esempio diapositive, dispense, esercizi, bibliografia) e le comunicazioni della/del docente specifiche per l'insegnamento sono reperibili all'interno della piattaforma Moodle › blended.uniurb.it
Attività di Supporto
Previo accordo con gli studenti, nell'ultima settimana di corso si potrà dedicare una lezione a una prova di relazione orale su testi scientifici del settore scelti dagli studenti stessi tramite ricerca backward o forward a partire dai materiali caricati su Blended Learning (o uno dei testi indicati in "Testi di studio") e in base ai loro interessi individuali. La prova, finalizzata a meglio comprendere le modalità della terza fase d'esame (vedi "Modalità di accertamento"), non avrà alcun impatto sulla valutazione finale dello studente.
Modalità Didattiche, Obblighi, Testi di Studio e Modalità di Accertamento
- Modalità didattiche
Lezioni frontali. Eventuali relazioni da parte degli studenti.
- Didattica innovativa
Flipped Classroom. Brevi relazioni svolte dagli studenti su letture scientifiche selezionate da loro stessi (vedi "Attività di supporto" e "Modalità di accertamento").
- Obblighi
Essendo un corso rivolto a iscritti ad una Laurea Magistrale, si danno per scontate le nozioni di Linguistica generale ottenibili tramite un corso di base di livello Triennale. Il corso prevede in particolare una conoscenza di base dell'Alfabeto Fonetico Internazionale. Un testo a tal proposito utile al ripasso è indicato in "Testi di studio" (Mioni, 2001).
- Testi di studio
Il programma è uguale per frequentanti e non frequentanti. Per dare la possibilità agli studenti non frequentanti di apprendere tramite studio individuale quanto spiegato durante le lezioni, si consiglia vivamente di fare uso delle indicazioni e dei materiali caricati su Blended Learning, utili appunto a raggiungere il livello di preparazione previsto dal corso.
Oltre alle diapositive del corso caricate su Blended Learning, tutti gli studenti sono tenuti a preparare per l'esame i seguenti testi:
- Berruto, G., Cerruti, M. (2019). Manuale di sociolinguistica. Torino: UTET.
- Piccardi, D. (2022). Carlo Alberto Mastrelli e la simbologia del segno. Storia di un ultimo progetto. In Parenti, A. (a cura di), Il Circolo Linguistico Fiorentino. Testimonianze e frammenti. Firenze: Olschki, 69-101.
Di seguito sono elencati una serie di testi per area di pertinenza utili all'approfondimento individuale. Non sono obbligatori per il superamento dell'esame.
[Per un ripasso dell'Alfabeto Fonetico Internazionale]
- Mioni, A. M. (2001). Elementi di fonetica. Padova: Unipress.
[Per gli argomenti di sociolinguistica della variazione]
- Chambers, J. K., Shilling, N. (Eds., 2013). The Handbook of Language Variation and Change. Second Edition. Chichester: Wiley-Blackwell.
[Per gli atteggiamenti]
- Garrett, P. (2010). Attitudes to Language. Cambridge: Cambridge University Press.
[Opere di ampio respiro su temi di linguistica della scrittura]
- Coulmas, F. (2003). Writing Systems. An Introduction to their Linguistic Analysis. Cambridge: Cambridge University Press.
- Lillis, T. (2013). The Sociolinguistics of Writing. Edinburgh: Edinburgh University Press.
[Per il fonosimbolismo]
- Nobile, L., Lombardi Vallauri, E. (2016). Onomatopea e fonosimbolismo. Roma: Carocci.
- Modalità di
accertamento Colloquio orale (circa trenta minuti) in tre fasi.
Le prime due consistono in due domande atte a valutare la preparazione dello studente sui temi del corso e sui testi in programma.
La terza fase dell'esame valuterà la capacità dello studente di relazionare sinteticamente su un testo scientifico a sua scelta. Prima dell'esame, lo studente dovrà
- Effettuare una ricerca backward (tramite elenco dei riferimenti bibliografici di un testo) o forward (tramite liste di testi che citano un altro lavoro ottenibili tramite motori di ricerca di letteratura scientifica) a partire da uno dei testi di approfondimento caricati o indicati su Blended Learning, o da uno dei testi presenti nella sezione "Testi di studio" di questa pagina.
- Scegliere un articolo in italiano o inglese di suo interesse, seguendo un criterio di pertinenza con gli argomenti trattati nel corso (si veda il temario di riferimento in "Programma").
- Preparare una relazione orale di massimo quindici minuti su di esso.
- Inserire nel Foglio di lavoro condiviso su Blended gli estremi bibliografici dell'articolo su cui si intende relazionare almeno una settimana prima dall'appello d'esame a cui si intende partecipare.
Le risposte alle tre fasi dell'esame saranno valutate tenendo conto della conoscenza dei concetti spiegati durante il corso, della padronanza del linguaggio specifico e della dimostrazione di spirito critico (individuazione delle ragioni dietro ai concetti espressi e esemplificazione degli stessi; nel caso della terza fase, riconoscimento della pertinenza di un testo rispetto agli argomenti del corso). A ciascuna di queste tre dimensioni il docente attribuirà un giudizio qualitativo su quattro livelli (insufficiente - sufficiente - buono - eccellente). Per passare l'esame con il minimo della valutazione in trentesimi sarà bastevole reagire a due delle tre fasi in maniera complessivamente sufficiente. Il massimo dei voti con lode non sarà ottenibile senza una risposta eccellente alla terza fase dell'esame.
- Disabilità e DSA
Le studentesse e gli studenti che hanno registrato la certificazione di disabilità o la certificazione di DSA presso l'Ufficio Inclusione e diritto allo studio, possono chiedere di utilizzare le mappe concettuali (per parole chiave) durante la prova di esame.
A tal fine, è necessario inviare le mappe, due settimane prima dell’appello di esame, alla o al docente del corso, che ne verificherà la coerenza con le indicazioni delle linee guida di ateneo e potrà chiederne la modifica.
Informazioni aggiuntive per studentesse e studenti non Frequentanti
- Modalità didattiche
Studio individuale.
- Obblighi
Essendo un corso rivolto a iscritti ad una Laurea Magistrale, si danno per scontate le nozioni di Linguistica generale ottenibili tramite un corso di base di livello Triennale. Il corso prevede in particolare una conoscenza di base dell'Alfabeto Fonetico Internazionale. Un testo a tal proposito utile al ripasso è indicato in "Testi di studio" (Mioni, 2001).
- Testi di studio
Il programma è uguale per frequentanti e non frequentanti. Per dare la possibilità agli studenti non frequentanti di apprendere tramite studio individuale quanto spiegato durante le lezioni, si consiglia vivamente di fare uso delle indicazioni e dei materiali caricati su Blended Learning, utili appunto a raggiungere il livello di preparazione previsto dal corso.
Oltre alle diapositive del corso caricate su Blended Learning, tutti gli studenti sono tenuti a preparare per l'esame i seguenti testi:
- Berruto, G., Cerruti, M. (2019). Manuale di sociolinguistica. Torino: UTET.
- Piccardi, D. (2022). Carlo Alberto Mastrelli e la simbologia del segno. Storia di un ultimo progetto. In Parenti, A. (a cura di), Il Circolo Linguistico Fiorentino. Testimonianze e frammenti. Firenze: Olschki, 69-101.
Di seguito sono elencati una serie di testi per area di pertinenza utili all'approfondimento individuale. Non sono obbligatori per il superamento dell'esame.
[Per un ripasso dell'Alfabeto Fonetico Internazionale]
- Mioni, A. M. (2001). Elementi di fonetica. Padova: Unipress.
[Per gli argomenti di sociolinguistica della variazione]
- Chambers, J. K., Shilling, N. (Eds., 2013). The Handbook of Language Variation and Change. Second Edition. Chichester: Wiley-Blackwell.
[Per gli atteggiamenti]
- Garrett, P. (2010). Attitudes to Language. Cambridge: Cambridge University Press.
[Opere di ampio respiro su temi di linguistica della scrittura]
- Coulmas, F. (2003). Writing Systems. An Introduction to their Linguistic Analysis. Cambridge: Cambridge University Press.
- Lillis, T. (2013). The Sociolinguistics of Writing. Edinburgh: Edinburgh University Press.
[Per il fonosimbolismo]
- Nobile, L., Lombardi Vallauri, E. (2016). Onomatopea e fonosimbolismo. Roma: Carocci.
- Modalità di
accertamento Colloquio orale (circa trenta minuti) in tre fasi.
Le prime due consistono in due domande atte a valutare la preparazione dello studente sui temi del corso e sui testi in programma.
La terza fase dell'esame valuterà la capacità dello studente di relazionare sinteticamente su un testo scientifico a sua scelta. Prima dell'esame, lo studente dovrà
- Effettuare una ricerca backward (tramite elenco dei riferimenti bibliografici di un testo) o forward (tramite liste di testi che citano un altro lavoro ottenibili tramite motori di ricerca di letteratura scientifica) a partire da uno dei testi di approfondimento caricati o indicati su Blended Learning, o da uno dei testi presenti nella sezione "Testi di studio" di questa pagina.
- Scegliere un articolo in italiano o inglese di suo interesse, seguendo un criterio di pertinenza con gli argomenti trattati nel corso (si veda il temario di riferimento in "Programma").
- Preparare una relazione orale di massimo quindici minuti su di esso.
- Inserire nel Foglio di lavoro condiviso su Blended gli estremi bibliografici dell'articolo su cui si intende relazionare almeno una settimana prima dall'appello d'esame a cui si intende partecipare.
Le risposte alle tre fasi dell'esame saranno valutate tenendo conto della conoscenza dei concetti spiegati durante il corso, della padronanza del linguaggio specifico e della dimostrazione di spirito critico (individuazione delle ragioni dietro ai concetti espressi e esemplificazione degli stessi; nel caso della terza fase, riconoscimento della pertinenza di un testo rispetto agli argomenti del corso). A ciascuna di queste tre dimensioni il docente attribuirà un giudizio qualitativo su quattro livelli (insufficiente - sufficiente - buono - eccellente). Per passare l'esame con il minimo della valutazione in trentesimi sarà bastevole reagire a due delle tre fasi in maniera complessivamente sufficiente. Il massimo dei voti con lode non sarà ottenibile senza una risposta eccellente alla terza fase dell'esame.
- Disabilità e DSA
Le studentesse e gli studenti che hanno registrato la certificazione di disabilità o la certificazione di DSA presso l'Ufficio Inclusione e diritto allo studio, possono chiedere di utilizzare le mappe concettuali (per parole chiave) durante la prova di esame.
A tal fine, è necessario inviare le mappe, due settimane prima dell’appello di esame, alla o al docente del corso, che ne verificherà la coerenza con le indicazioni delle linee guida di ateneo e potrà chiederne la modifica.
| « torna indietro | Ultimo aggiornamento: 14/06/2025 |