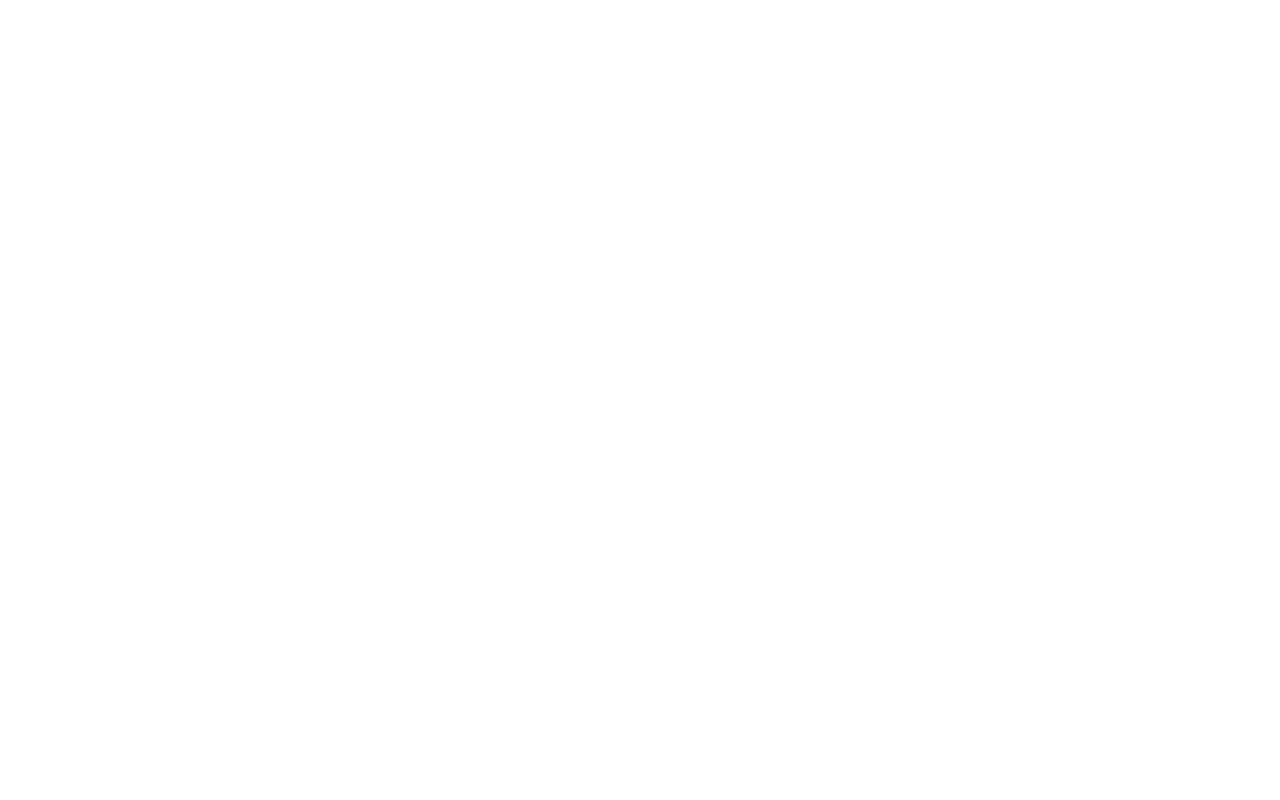LETTERATURA ITALIANA
| A.A. | CFU |
|---|---|
| 2010/2011 | 10 |
| Docente | Ricevimento studentesse e studenti | |
|---|---|---|
| Gualtiero De Santi |
Assegnato al Corso di Studio
| Giorno | Orario | Aula |
|---|
Obiettivi Formativi
La letteratura italiana è ricca di opere in cui si fa uso del dialetto (ciò sin dal Cinquecento, e ancor prima con il plurilinguismo dantesco). Attraverso testi del Settecento e dell'Ottocento - una commedia di Carlo Goldoni e i sonetti del Belli - il corso si propone di affrontare i problemi connessi all'uso del gergo, della lingua dialettale, del suo ibridarsi e contaminarsi, sul piano letterario, con l'italiano. Il Novecento verrà affrontato dalle particolarissime angolazioni di un poeta giocoso e teatrale (Eugenio Pazzini) e di un poeta di una generazione successiva (Franco Loi) che utilizza il dialetto nelle forme di un "métissage" esemplato sullo zoccolo del milanese. Congiuntamente verrà analizzato il lavoro svolto da una rivista specializzata nell'ambito della poesia neo-volgare, "Il Parlar franco".
L'approccio a una forma espressiva legata linguisticamente alla realtà apre un quadro d'analisi vitale e produttivo, anche perché non accademico. Gli obiettivi formativi vertono perciò su una precipua percezione del fare letterario oltreché dei legami che in questo caso esso intrattiene con la società. Il richiamo a modelli culturali diversi consente un ampio ventaglio di analisi e di riflessioni (spaziando dalla lirica al teatro, da modelli di rappresentazione sociale e antropologica al processo di produzione di una rivista letteraria).
Programma
1. Il veneto teatrale di Carlo Goldoni.
2. La Roma di Giuseppe Gioacchino Belli.
3. La figura e le "zirudele" di Eugenio Pazzini.
4. Problemi di teoria.
5. Franco Loi e la "miscela esplosiva" del dialetto.
6. La vicenda de "Il Parlar franco".
Attività di Supporto
Proiezioni di video di rappresentazioni teatrali.
Ascolto di registrazioni sonore.
Incontri con poeti neo-volgari, editori e critici.
Modalità Didattiche, Obblighi, Testi di Studio e Modalità di Accertamento
- Modalità didattiche
Lezione frontale.
Seminari.
Lezioni sulla letteratura del Novecento e sull'elaborazione di testi scritti condotte dal prof. Mirco Ballabene.
- Obblighi
Obbligo di frequenza di almeno una metà delle lezioni.
- Testi di studio
1. C. Goldoni, "Le baruffe chiozzotte", prefazione di L. Lunari, Milano, Rizzoli,.
2. G. G. Belli, "Sonetti", con saggi di P. Gibellini e G. Vigolo, Milano, Mondadori, .
3. E. Pazzini, "Versi in dialetto romagnolo - Antologia", prefazione di A. Prete, Villa Verucchio, Pazzini, 2006.
4. D. Pazzini (a cura di), "Voci sulla collina", Studi su Eugenio Pazzini, Villa Verucchio (Rn), Pazzini editore, 2000.
5. F. Loi, "Aria de la memoria", Torino, Einaudi, 2005.
6. "Il Parlar franco" n. 10 (2010), Pazzini editore.
7. G. Ferroni, A. Cortellessa, I. Pantani, S. Tatti, "Storia e testi della letteratura italiana", Vol. X, "Ricostruzione e sviluppo nel dopoguerra (1945-1968)", Milano, Mondadori Università, 2005, pp. 41-42; 47-72; 93-99; 102-103; 110-119; 345-371; 406-412; 441-468.
N. B. - Si richiede la conoscenza dei saggi, come delle prefazioni, postfazioni, introduzione menzionati nella biografia su acclusa.
- Modalità di
accertamento Esame orale con una prova scritta non propedeutica, che verterà su argomenti del corso e tematiche di attualità culturale.
Sono previste anche relazioni scritte.
- Disabilità e DSA
Le studentesse e gli studenti che hanno registrato la certificazione di disabilità o la certificazione di DSA presso l'Ufficio Inclusione e diritto allo studio, possono chiedere di utilizzare le mappe concettuali (per parole chiave) durante la prova di esame.
A tal fine, è necessario inviare le mappe, due settimane prima dell’appello di esame, alla o al docente del corso, che ne verificherà la coerenza con le indicazioni delle linee guida di ateneo e potrà chiederne la modifica.
Informazioni aggiuntive per studentesse e studenti non Frequentanti
- Modalità didattiche
Lezione frontale.
- Testi di studio
1. C. Goldoni, "Le baruffe chiozzotte", prefazione di L. Lunari, cronologia bibliografia e note di C. Pedretti, Milano, Rizzoli, 2000.
2. G. G. Belli, "Sonetti", con introduzione, note e cronologia di P. Gibellini e commento di G. Vigolo, Milano, Mondadori, 1990.
3. E. Pazzini, "Versi in dialetto romagnolo - Antologia", prefazione di A. Prete, Villa Verucchio, Pazzini, 2006.
4. D. Pazzini (a cura di), "Voci sulla collina", Studi su Eugenio Pazzini, Villa Verucchio (Rn), Pazzini editore, 2000.
5. F. Loi, "Aria de la memoria", Torino, Einaudi, 2005.
6. "Il Parlar franco" n. 10 (2010), Pazzini editore.
7. "Il Parlar franco" n. 7 (2007), Pazzini editore.
7. G. Ferroni, A. Cortellessa, I. Pantani, S. Tatti, "Storia e testi della letteratura italiana", Vol. X, "Ricostruzione e sviluppo nel dopoguerra (1945-1968)", Milano, Mondadori Università, 2005, pp. 41-42; 47-72; 93-99; 102-103; 110-119; 345-371; 406-412; 441-468.
N. B. - Si richiede la conoscenza dei saggi, come delle prefazioni, postfazioni, introduzione menzionati nella biografia su acclusa.
- Modalità di
accertamento Esame orale.
- Disabilità e DSA
Le studentesse e gli studenti che hanno registrato la certificazione di disabilità o la certificazione di DSA presso l'Ufficio Inclusione e diritto allo studio, possono chiedere di utilizzare le mappe concettuali (per parole chiave) durante la prova di esame.
A tal fine, è necessario inviare le mappe, due settimane prima dell’appello di esame, alla o al docente del corso, che ne verificherà la coerenza con le indicazioni delle linee guida di ateneo e potrà chiederne la modifica.
| « torna indietro | Ultimo aggiornamento: 29/07/2010 |