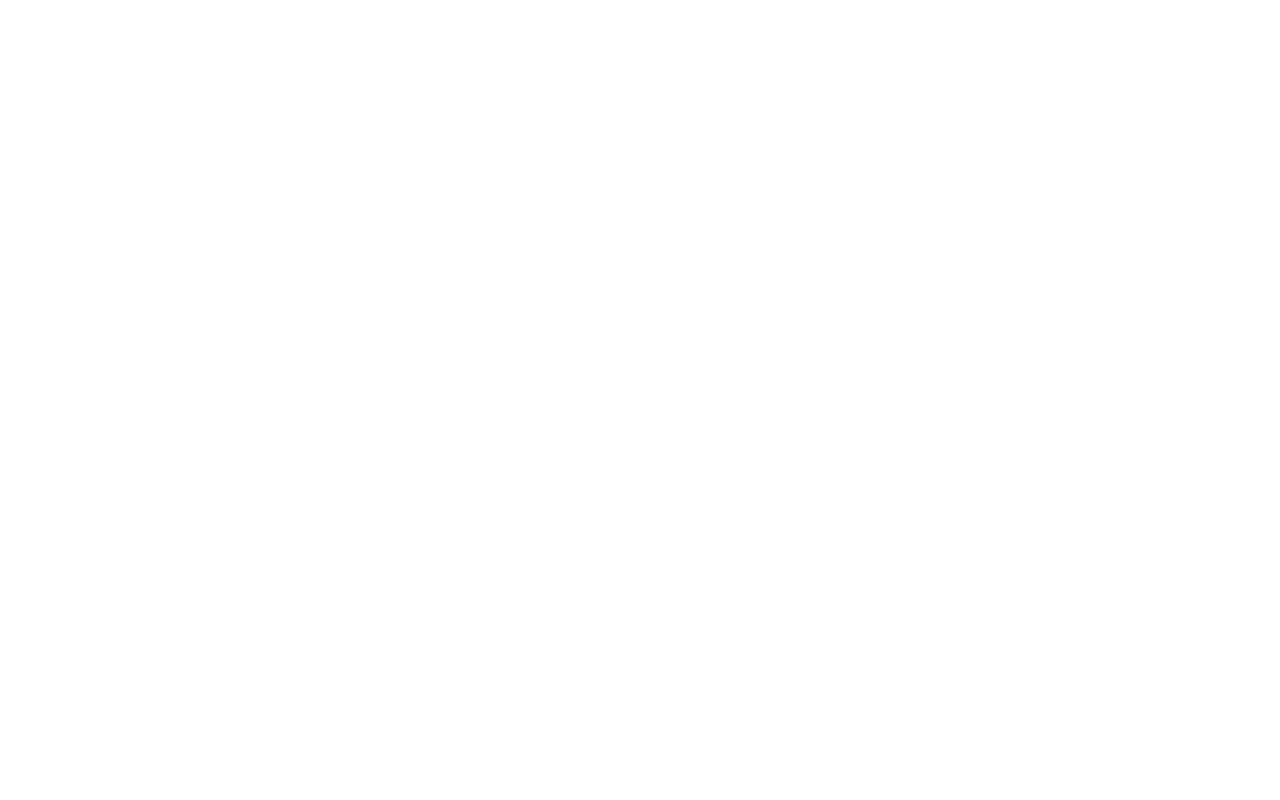LINGUISTICA ITALIANA I E DIDATTICA DELLA LINGUA
ITALIAN LINGUISTICS AND DIDACTICS OF LANGUAGE I
| A.A. | CFU |
|---|---|
| 2025/2026 | 6 |
| Docente | Ricevimento studentesse e studenti | |
|---|---|---|
| Monica Alba | Lunedì ore 10:00-12:00. Contattare la docente per fissare un appuntamento. |
Assegnato al Corso di Studio
| Giorno | Orario | Aula |
|---|
| Giorno | Orario | Aula |
|---|
Obiettivi Formativi
Il corso si propone di fornire le conoscenze di base sulle strutture grammaticali dell’italiano e sulla riflessione sociolinguistica dell'italiano contemporaneo, al fine di acquisire gli strumenti d’analisi necessari per un corretto uso della lingua nella comprensione e produzione di testi orali e scritti, e nella didattica della disciplina.
Programma
Il corso, concepito per andare incontro alle necessità dei futuri insegnanti di scuola primaria, intende fornire una solida base di conoscenze linguistiche necessarie per l’insegnamento dell’italiano. La prima parte del corso affronterà gli aspetti fondamentali della storia della lingua italiana, dalle origini ai processi di diffusione, con particolare attenzione al ruolo che ebbe la scuola. Seguirà un approfondimento relativo alla nascita dell’educazione linguistica democratica, alla riflessione metalinguistica e alla promozione del plurilinguismo nella scuola, anche attraverso l’analisi delle Indicazioni Nazionali per il curricolo. In questa prima parte saranno inoltre introdotte nozioni di sociolinguistica, con particolare attenzione alla varietà dell’italiano contemporaneo e alle strutture grammaticali della lingua (fonetica, morfologia, lessico, sintassi, testualità). La seconda parte del corso sarà dedicata allo studio della lingua del cibo, esempio vivace di lingua settoriale, e agli strumenti didattici per l'insegnamento dell’italiano nella scuola primaria, con particolare attenzione alle strategie per lo sviluppo delle competenze linguistiche orali e scritte, alla costruzione del lessico e all’educazione alla testualità.
Il corso, della durata complessiva di 36 ore, è suddiviso in 18 incontri di due ore ciascuno ed è così articolato:
- Nozioni minime di storia della lingua italiana (2 lezioni)
- L’educazione linguistica democratica: linguisti e maestri (3 lezioni)
- Il repertorio linguistico degli italiani (3 lezioni)
- Nozioni di fonetica e di fonologia (2 lezioni)
- Morfologia, Lessico e didattica del lessico (3 lezioni)
- Elementi di linguistica testuale ed educazione alla testualità (2 lezioni)
- La lingua del cibo come lingua settoriale (2 lezioni)
- La lingua del cibo nella didattica (1 lezione)
Risultati di Apprendimento (Descrittori di Dublino)
Conoscenza e capacità di comprensione (knowledge and understanding)
Alla fine del corso lo studente sarà in grado di
- conoscere le strutture fondamentali della lingua italiana;
- conoscere e comprendere le questioni relative alla variabilità della lingua;
- conoscere e comprendere lo spazio linguistico italiano;
- conoscere e comprendere le caratteristiche dell’italiano contemporaneo in rapporto alle situazioni comunicative e ai tipi di testi;
- conoscere le principali caratteristiche della lingua del cibo, intesa come lingua settoriale, e di saperne tracciare le tappe più importanti della sua storia;
- conoscere e comprendere l’importanza del ruolo dell’educazione linguistica nel contesto scolastico e nel contesto più ampio della vita sociale;
- riflettere autonomamente e criticamente rispetto alla didattica della lingua italiana;
- conoscere la terminologia tecnica;
Conoscenza e capacità di comprensione applicate (applying knowledge and understanding)
Alla fine del corso lo studente avrà mostrato:
- di avere sicura competenza linguistica;
- di saper riconoscere le varietà e gli usi della lingua italiana;
- di conoscere lo spazio linguistico italiano;
- di avere capacità di analisi metalinguistica;
- di saper descrivere le principali caratteristiche della lingua del cibo come lingua settoriale;
- di avere una conoscenza critica dei principali modelli e strumenti dell’educazione linguistica;
- di applicare adeguate strategie didattiche nell’ambito della disciplina;
Autonomia di giudizio (making judgements):
Alla fine del corso lo studente dovrà dimostrare l'attitudine a:
- riconoscere temi e problemi relativi alla disciplina;
- valutare criticamente i fenomeni culturali attraverso l’analisi linguistica;
- riapplicare autonomamente i metodi dell’analisi descrittiva;
- analizzare materiali didattici idonei alla scuola dell’infanzia e primaria;
- riflettere e progettare un'unità didattica volta allo sviluppo della competenza linguistica dell’apprendente.
Abilità comunicative (communication skills);
Al termine del corso, lo studente dovrà aver acquisito:
- la capacità di esprimere con chiarezza i contenuti del corso;
- padronanza del lessico tecnico della linguistica italiana;
Capacità di apprendere (learning skills)
Al termine del corso, lo studente dovrà aver acquistito:
- la capacità di riflettere sulla lingua intesa come fenomeno storico, sociale e culturale;
- la capacità di interpretare i dati linguistici con senso critico;
- la capacità di utilzzare e reperire autonomamente le fonti bibliografiche per lo studio e l’insegnamento della lingua italiana.
Materiale Didattico
Il materiale didattico predisposto dalla/dal docente in aggiunta ai testi consigliati (come ad esempio diapositive, dispense, esercizi, bibliografia) e le comunicazioni della/del docente specifiche per l'insegnamento sono reperibili all'interno della piattaforma Moodle › blended.uniurb.it
Attività di Supporto
E' prevista una prova formativa di autovalutazione.
Modalità Didattiche, Obblighi, Testi di Studio e Modalità di Accertamento
- Modalità didattiche
Lezioni frontali.
- Testi di studio
- R. Setti, La scoperta della lingua italiana. Linguistica per insegnare nella scuola dell'infanzia e primaria, Firenze, Cesati, 2019 (capp. II - III - V).
- R. Cella, Nozioni minime di storia della lingua e della grammatica italiane per insegnanti di scuola primaria, in R. Setti, C. De Santis, R. Cella (a cura di), Per una didattica della parole. Ascoltare, parlare, leggere e scrivere nella scuola primaria, Firenze, Franco Cesati, 2021, pp. 103-117;
- M. G. Lo Duca, Lingua italiana ed educazione linguistica. Tra storia ricerca e didattica, Roma, Carocci, 2019 (nuova ristampa), relativamente ai seguenti capitoli: I, II, III;
- G. Frosini, S. Lubello, L'italiano del cibo, Carocci, Roma, 2023 (in particolare, i capitoli seguenti: I, II, III).
Per gli studenti frequentanti, l'acquisto dei testi non è obbligatorio, ma consigliato. Si segnalano come materiale di approfondimento per i temi affrontati in aula. Le diapositive delle lezioni sono sempre caricate sulla pagina Moodle dedicata al corso.
- Modalità di
accertamento I risultati di apprendimento attesi verranno valutati attraverso una prova scritta consistente in un questionario con 12 domande a risposta multipla (ogni risposta corretta attribuisce 1 punto), 2 a risposta aperta breve (risposte concise e specifiche, tra 5 e 8 righe, ciascuna valutata con un punteggio compreso tra 0 e 5 punti) e 1 a risposta aperta lunga (risposta più estesa e dettagliata, tra 10 e 15 righe, con un punteggio massimo di 11 punti).
Per le domande a risposta aperta (breve e lunga), i criteri di valutazione sono i seguenti: livello di correttezza formale; pertinenza ed efficacia delle risposte in rapporto ai contenuti del programma; adeguatezza del linguaggio disciplinare utilizzato. La valutazione finale è ottenuta dalla somma dei punteggi ottenuti nei singoli quesiti e sarà espressa in trentesimi. Il tempo a disposizione per rispondere alle domande proposte è di 80 minuti.
- Disabilità e DSA
Le studentesse e gli studenti che hanno registrato la certificazione di disabilità o la certificazione di DSA presso l'Ufficio Inclusione e diritto allo studio, possono chiedere di utilizzare le mappe concettuali (per parole chiave) durante la prova di esame.
A tal fine, è necessario inviare le mappe, due settimane prima dell’appello di esame, alla o al docente del corso, che ne verificherà la coerenza con le indicazioni delle linee guida di ateneo e potrà chiederne la modifica.
Informazioni aggiuntive per studentesse e studenti non Frequentanti
- Modalità didattiche
Studio individuale. Gli studenti non frequentanti dovranno seguire le indicazioni bibliografiche riportate nell’apposita sezione di questa scheda e sono invitati a consultare le slide discusse a lezione, disponibili sulla piattaforma Moodle.
- Testi di studio
- R. Setti, La scoperta della lingua italiana. Linguistica per insegnare nella scuola dell'infanzia e primaria, Firenze, Cesati, 2019.
- R. Cella, Nozioni minime di storia della lingua e della grammatica italiane per insegnanti di scuola primaria, in R. Setti, C. De Santis, R. Cella (a cura di), Per una didattica della parole. Ascoltare, parlare, leggere e scrivere nella scuola primaria, Firenze, Franco Cesati, 2021, pp. 103-117;
- M. G. Lo Duca, Lingua italiana ed educazione linguistica. Tra storia ricerca e didattica, Roma, Carocci, 2019 (nuova ristampa), cap. I, II, III;
- G. Frosini, S. Lubello, L'italiano del cibo, Carocci, Roma, 2023 (in particolare, i cap. I, II, III);
- P. D'Achille, L'italiano contemporaneo, Bologna, il Mulino, 2019 (solo il cap. III).
- Modalità di
accertamento I risultati di apprendimento attesi verranno valutati attraverso una prova scritta consistente in un questionario con 12 domande a risposta multipla (ogni risposta corretta attribuisce 1 punto), 2 a risposta aperta breve (risposte concise e specifiche, tra 5 e 8 righe, ciascuna valutata con un punteggio compreso tra 0 e 5 punti) e 1 a risposta aperta lunga (risposta più estesa e dettagliata, tra 10 e 15 righe, con un punteggio massimo di 11 punti).
Per le domande a risposta aperta (breve e lunga), i criteri di valutazione sono i seguenti: livello di correttezza formale; pertinenza ed efficacia delle risposte in rapporto ai contenuti del programma; adeguatezza del linguaggio disciplinare utilizzato. La valutazione finale è ottenuta dalla somma dei punteggi ottenuti nei singoli quesiti e sarà espressa in trentesimi. Il tempo a disposizione per rispondere alle domande proposte è di 80 minuti.
- Disabilità e DSA
Le studentesse e gli studenti che hanno registrato la certificazione di disabilità o la certificazione di DSA presso l'Ufficio Inclusione e diritto allo studio, possono chiedere di utilizzare le mappe concettuali (per parole chiave) durante la prova di esame.
A tal fine, è necessario inviare le mappe, due settimane prima dell’appello di esame, alla o al docente del corso, che ne verificherà la coerenza con le indicazioni delle linee guida di ateneo e potrà chiederne la modifica.
| « torna indietro | Ultimo aggiornamento: 09/07/2025 |